Showing posts with label recensione. Show all posts
Showing posts with label recensione. Show all posts
17 May 2021
05 May 2021
LA CAMPANA DI VETRO DI SYLVIA PLATH - di Rafael Becerra (Traduzione di Silvia Pantò)
È difficile capire le ragioni di un suicida. La scala di valori alla quale ci atteniamo normalmente non fornisce alcuna spiegazione sull'atto di togliersi la vita. In molti casi le ragioni del suicida, sono relazionate ad alcune circostanze che, unite ad una considerevole dose di disperazione, portano l'individuo a mettere fine alla propria vita, in un momento di crisi. Ma quando sono gli squilibri della mente a spingere una persona al suicidio, le spiegazioni ed i ragionamenti a riguardo sono superflui.
La campana di vetro, è un libro più che premonitore, si potrebbe dire, perché pubblicato quasi in contemporanea al suicidio dell'autrice. Fu pubblicato subito dopo la sua morte. La protagonista del libro, Ester Greenwood, è la stessa Sylvya Plath, che narra l'intimo viaggio verso la pazzia, la successiva guarigione e reinserimento nella società. In realtà, questo reinserimento si trasformò nella sua fine.
Da sempre, le persone che si tolgono la vita hanno attirato la mia attenzione. Un certo sentimento di rispetto e ammirazione, visto il coraggio nascosto dietro al gesto. Sono però caduto nell'errore di pensarlo come un atto premeditato. Proprio due anni fa ho vissuto da vicino il suicidio di una donna, sorella di un mio caro amico. Questa persona, professoressa, madre di due bambini, e apparentemente normale, conduceva una vita tranquilla e monotona, come quasi tutti noi, fino a quando qualcosa cominciò a rompersi nella sua mente, cominciò a dire di volersi togliere la vita. Suo fratello, senza ancora essersi reso conto dell'accaduto, mi raccontò con tristezza tutte le fasi che la donna aveva attraversato, fino a raggiungere il suo obiettivo. Ascoltare questo racconto fu sconvolgente: -Le voci mi dicono ucciditi! Credo che non c'è bisogno di soffermarsi ancora di più sul caso, già che nessuna congettura sfoderata dalla ragione ci farebbe arrivare ad una conclusione plausibile.
Sylvia Plath si suicidò nel 1963. La campana di vetro, il suo primo romanzo che ho letto, mi ha fatto scoprire un'autrice dalla sincerità spiazzante, e il suo sguardo allo stesso tempo lucido e freddo, nascosto nelle pieghe del suo personaggio. Mostra, senza maschere, che le cose più semplici della vita possono essere progetti impossibili per quelle persone che rimangono chiuse all'interno questa campana immaginaria. La similitudine tra l'autrice e il suo personaggio è devastante. 31 anni, una vita corta per quel che può sembrare a noi, ma un eternità che pesa come un macigno per quelli che non riescono a sopportare il peso della propria esistenza. La sensibilità di questa donna invita ad immergersi nei suoi scritti, nelle sue poesie, che vi trascineranno in pieno verso il suo cuore e la sua mente. Poesia confessionale l'hanno definita, con l'ansia di classificare tutto, come se il fatto di porre un'etichetta ci desse la sicurezza che quello che leggiamo fosse catalogabile, quasi per farlo diventare innoquo, affinchè non ci faccia male. Si sbagliano. Sì, che può far male! La poesia, sono i cocci di cui si compone una persona. Non possono venire assemblati per appartenere a questo genere letterario o a quell'altra categoria, devono piuttosto spingerci al bordo del pozzo dal quale sono emersi, obbligandoci ad affacciarci e a guardarci dentro, anche solo per un istante, per vedere quanto sia spaventoso, ma allo stesso tempo bellissimo, vivere.
Rafael Becerra
28 April 2021
LE TANTE MORTI DI AMBROSE BIERCE di Rafael Becerra (Traduzione di Silvia Pantò)
Per quanto molto conosciuta, non è della sua misteriosa scomparsa che voglio, ma delle tante morti che una persona si ritrova a dover affrontare nella propria vita, quelle che forgiano il carattere perché originate da circostanze dolorose, che possono condizionarci per tutta la vita. Questo fu il caso di Bierce, che gli inglesi soprannominarono Bitter Bierce, a causa dell'amarezza e della disillusione tipiche dei suoi scritti. Basta osservare la sua biografia per farsi venire un nodo in gola.
Essere il più giovane di nove fratelli, di una famiglia umile, in un villaggio dell'Ohio nel 1842, non può essere definita una fortuna, cosa che pensava anche Bierce, e da cui nasceva l'odio verso la propria famiglia. Suo fratello Albert era l'unico che sfuggiva all'ira della sua penna, non si sa bene perchè, ma si può intuire facilmente. Era sua madre il vero capo famiglia, calvinista e puritana, gestiva con rigore le vite dei propri figli e del marito scansafatiche, con la frusta in una mano e la bibbia nell'altra.
È in questo ambiente repressivo e pieno di pregiudizi che crebbero i nove figli e non c'era da meravigliarsi se tutti desiderassero scappare da lì. Uno dei suoi fratelli fuggì con un circo e un'altra sorella, andata in missione in Africa, ebbe un drammatico incidente relazionato alla dieta di alcuni indigeni.
A 17 anni Bierce entrò nell'accademia militare ma presto esplose la guerra di secessione che nel 1861 lo trascinò con sè. La tragedia della guerra si manifestò davanti gli occhi di quel ragazzo, con tutta la sua crudeltà e drammaticità; egli stesso ne farà le spese rimanendo gravemente ferito. Quest'esperienza così orribile fu ciò che ispirò buona parte delle sue opere. Difatti non vi era traccia d'invenzione alcuna nelle storie narrate in Nel mezzo della vita. Racconti di soldati e civili: ogni oscenità descritta, sia morale che fisica, fu realmente vissuta in prima persona da Bierce. I racconti contenuti in quest'opera sono quelli di persone segnate da un destino avverso. Un'opera pacifista, che mostra le ombre di uno spettacolo bellico misero e privo di grandezza. Molti studiosi considerano questa raccolta di racconti come la sua miglior opera.
A 17 anni Bierce entrò nell'accademia militare ma presto esplose la guerra di secessione che nel 1861 lo trascinò con sè. La tragedia della guerra si manifestò davanti gli occhi di quel ragazzo, con tutta la sua crudeltà e drammaticità; egli stesso ne farà le spese rimanendo gravemente ferito. Quest'esperienza così orribile fu ciò che ispirò buona parte delle sue opere. Difatti non vi era traccia d'invenzione alcuna nelle storie narrate in Nel mezzo della vita. Racconti di soldati e civili: ogni oscenità descritta, sia morale che fisica, fu realmente vissuta in prima persona da Bierce. I racconti contenuti in quest'opera sono quelli di persone segnate da un destino avverso. Un'opera pacifista, che mostra le ombre di uno spettacolo bellico misero e privo di grandezza. Molti studiosi considerano questa raccolta di racconti come la sua miglior opera.
Bierce si stabilì poi a San Francisco e iniziò a scrivere per diversi giornali, interessandosi alla politica locale, venendo nuovamente deluso anche da questo mondo. Fu però questo il periodo in cui incontrò Mark Twain, con il quale strinse una solida amicizia. In seguito andò a vivere a Londra per tre anni, forse il periodo migliore della sua vita. Successivamente si sposò, ma purtroppo non visse un matrimonio felice: due dei suoi figli morirono tragicamente, uno in una rissa e l'altro alcolizzato. Nel 1889 si separarò da sua moglie, dopo 18 anni di matrimonio. Nel 1876, una volta tornato a San Francisco, ricominciò a scrivere per giornali attraverso i quali raggiunse un grande prestigio. Stufo del suo amaro presente, si imbarcò in quella che risultò essere la sua ultima avventura. Realizzò, prima di tutto, un viaggio in cui ripercose i campi di battaglia della guerra di secessione americana, e nel 1913 partì per la guerra civile in Messico, luogo in cui si persero le sue tracce.
Bierce fu paragonato a scrittori come Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Edgar Allan Poe y Stephen Crane. Con un curriculum di questo livello, vale la pena immergersi nelle sue opere, perché si viene immediatamente catturati dal suo stile vivace, che trascina nelle storie, a volte terrificanti, altre violente, o fantastiche, con titoli davvero suggestivi come Il club dei parenticidi.
Un autore che continua a suscitare ammirazione e al quale è importante ritornare spesso per ricordarci che nessuna vanità, nessun cosa materiale, potrà salvarci dalla stupidità.
20 April 2021
LA CAMPANA DE CRISTAL de Sylvia Plath - por Rafael Becerra
Es difícil comprender las razones de un suicida. La escala de valores a las que nos atenemos las personas normalizadas no servirían para establecer ni para acercar una explicación al acto de quitarse la vida. En muchos casos esas razones pueden atender a determinadas circunstancias que junto con una buena dosis de desesperación llevan a la persona a terminar con su vida, quizás en un arrebato. Pero cuando es la mente distorsionada la que lo empuja al suicidio, las explicaciones o razonamientos quedan fuera de la ecuación.
La campana de cristal, es un libro, más que premonitorio, se podría decir, contemporáneo con el suicidio de su autora: Sylvia Plath. Fue publicado tras su muerte, y su protagonista, Ester Greenwood es ella misma, narrando el viaje íntimo hacía la locura y su posterior recuperación e integración en la sociedad. En la realidad, esa integración se transformó en su propio fin.
Siempre he tenido en alta consideración a las personas que se quitan la vida. Cierto sentimiento de respeto y admiración, dada la valentía del acto. Pero he caído en el error casi siempre de pensar en ello como un acto premeditado. Hace apenas dos años viví de cerca el suicidio de una mujer, hermana de un buen amigo. Esta persona, profesora, madre de dos hijos, y aparentemente normal, llevaba una vida tranquila y monótona como casi todos nosotros, hasta que algo comenzó a romperse dentro de su mente, y comenzó ha hablar de quitarse la vida. Su hermano, incapaz de comprenderla me narró con amargura los pasos que siguió hasta conseguir llevar a cabo su objetivo. Escuchar ese relato es estremecedor: -¡Las voces me dicen mátate! Creo que no hace falta ahondar más en el caso, ya que ninguna conjetura lanzada desde la razón nos haría llegar a ninguna conclusión plausible.
Sylvia Plath se suicidó en 1963, la La campana de cristal es la primera novela que leo de ella, pero me ha descubierto a una autora de una sinceridad brutal, su mirada encubierta en su personaje, de una lucidez y una frialdad terrible y hermosa al mismo tiempo. Muestra sin disfraz que las cosas más sencillas de la vida pueden ser proyectos imposibles para aquellas personas encerradas bajo esa campana imaginaria. El símil es demoledor. 31 años, una corta vida según lo podríamos ver nosotros, pero toda una eternidad que pesa como una losa para aquellos que no pueden soportar el peso de la misma. La sensibilidad de esta mujer invita a sumergirse en sus escritos, en sus poemas, que te arrastran de lleno a su corazón y su mente. Poesía confesional la nombraron algunos, en ese afán de tener todo clasificado, como si el hecho de poner una etiqueta nos diera la seguridad de que lo que leamos allí, ya está catalogado, ya no puede hacernos daño. Se equivocan. Sí que puede, la poesía que son trozos de una misma no se puede maquillar con clasificaciones ni etiquetas, siempre nos va a arrastrar al pozo de donde salieron, nos va a obligar a asomarnos al brocal y mirar dentro para que, aunque solo sea un instante, nos muestre lo terrible y hermoso que es vivir.
Rafael Becerra
05 April 2021
29 March 2021
Recensione di L'uomo Elefante e altri racconti - di Natalia Verginella (italiano)
Da bambina, nella biblioteca della nonna, amavo sfogliare un vecchio libro appartenuto al bisnonno con fotografie in bianco e nero di donne barbute, persone affette da nanismo, bimbi con piedi da elefante e altri “fenomeni da baraccone”. Li osservavo per ore nei dettagli cercando di capire cosa potessero provare in quelle pose bloccate tipiche delle fotografie dei primi Novecento.
Non so se è per questo ricordo dell'infanzia che nella mia libreria ci sono i dvd di Freaks, un film del 1932 diretto da Tod Browning, ambientato nel mondo del circo ed interpretato da veri e propri fenomeni da baraccone, e uno dei miei film preferiti, The Elephant Man di David Lynch. Proprio quest'ultimo è l'adattamento cinematografico del libro The Elephant Man and Other Reminiscences di sir Frederick Treves.
La casa editrice El Doctor Sax ne ha pubblicato la versione italiana L'uomo Elefante e altri racconti di Frederick Treves, tradotto abilmente da Armando Rotondi, e ovviamente da oggi è nella libreria di casa mia.
È un libro che si legge tutto d'un fiato. È piacevolmente semplice ma appassionante. I caratteri della copertina richiamano le locandine del circo dei primi del Novecento quando i fenomeni da baraccone erano una delle attrazioni, e l'immagine centrale creata da Marco De Luca richiama la figura dell'Uomo Elefante al centro di un mirino, al centro dello sguardo di tutti.
Frederick Treves è stato un grande chirurgo, un fine anatomista, e un abile scrittore. Racconta con attenzione per i dettagli, quasi come fosse un antropologo, il suo incontro e la sua amicizia con Joseph Merrick, il famoso Uomo Elefante, per tanto tempo esibito come fenomeno da baraccone nella Londra di fine Ottocento.
Treves non descrive di Merrick solo le deformità fisiche, ma delinea un ritratto intimo e personale con parole semplici, ma estremamente vivide che regalano al lettore dei preziosi quadri intimisti.
“Rinchiusa in un negozio vuoto e illuminato dalla debole luce blu del bruciatore a gas, questa figura ingobbita era l'incarnazione della solitudine...
Fuori splendeva il sole e si sentiva il via vai dei passanti, una melodia fischiettata da un ragazzo e il ronzio amichevole del traffico sulla strada.”
Grazie alla potenza di queste descrizioni, il lettore conosce non un fenomeno da baraccone, ma semplicemente un uomo, con le sue fragilità, i suoi sogni e le sue paure.
“Fu solo quando scoprii che Merrick era molto intelligente, che possedeva una sensibilità acuta e – ciò che è peggio – un'immaginazione romantica, che finalmente compresi la travolgente tragedia della sua vita.”
“Aveva una passione per la conversazione, ma per tutta la vita non aveva mai avuto nessuno con cui parlare.”
“Non aveva avuto un'infanzia. Non aveva avuto un'adolescenza. Non aveva mai provato piacere, Non sapeva nulla della gioia di vivere né del divertimento. La sua unica idea di felicità riguardava lo strisciare nell'oscurità per nascondersi.”
“ Era passato attraverso il fuoco e ne era uscito illeso. I suoi problemi lo avevano nobilitato.”
“Una cosa che mi aveva sempre colpito tristemente era il fatto che Merrick non potesse sorridere... Poteva piangere, ma non poteva sorridere.”
“Mi colpiva quando mi diceva che si era fatta strada nella sua mente l'idea, nell'ipotesi di vivere tra ciechi, di poter conquistare l'affetto di una donna, se solo fosse stata senza occhi per vedere.”
L'uomo Elefante e altri racconti di Frederick Treves è un piccolo capolavoro di verità, un'analisi estremamente attuale dell'uomo e della sua unicità.
Frederick Treves non descrive solo Joseph Merrick, l'uomo elefante, descrive me e forse tutti noi che ogni giorno lottiamo, nel centro del mirino, per farci accettare dagli altri semplicemente per quello che siamo.
Non so se è per questo ricordo dell'infanzia che nella mia libreria ci sono i dvd di Freaks, un film del 1932 diretto da Tod Browning, ambientato nel mondo del circo ed interpretato da veri e propri fenomeni da baraccone, e uno dei miei film preferiti, The Elephant Man di David Lynch. Proprio quest'ultimo è l'adattamento cinematografico del libro The Elephant Man and Other Reminiscences di sir Frederick Treves.
La casa editrice El Doctor Sax ne ha pubblicato la versione italiana L'uomo Elefante e altri racconti di Frederick Treves, tradotto abilmente da Armando Rotondi, e ovviamente da oggi è nella libreria di casa mia.
È un libro che si legge tutto d'un fiato. È piacevolmente semplice ma appassionante. I caratteri della copertina richiamano le locandine del circo dei primi del Novecento quando i fenomeni da baraccone erano una delle attrazioni, e l'immagine centrale creata da Marco De Luca richiama la figura dell'Uomo Elefante al centro di un mirino, al centro dello sguardo di tutti.
Frederick Treves è stato un grande chirurgo, un fine anatomista, e un abile scrittore. Racconta con attenzione per i dettagli, quasi come fosse un antropologo, il suo incontro e la sua amicizia con Joseph Merrick, il famoso Uomo Elefante, per tanto tempo esibito come fenomeno da baraccone nella Londra di fine Ottocento.
Treves non descrive di Merrick solo le deformità fisiche, ma delinea un ritratto intimo e personale con parole semplici, ma estremamente vivide che regalano al lettore dei preziosi quadri intimisti.
“Rinchiusa in un negozio vuoto e illuminato dalla debole luce blu del bruciatore a gas, questa figura ingobbita era l'incarnazione della solitudine...
Fuori splendeva il sole e si sentiva il via vai dei passanti, una melodia fischiettata da un ragazzo e il ronzio amichevole del traffico sulla strada.”
Grazie alla potenza di queste descrizioni, il lettore conosce non un fenomeno da baraccone, ma semplicemente un uomo, con le sue fragilità, i suoi sogni e le sue paure.
“Fu solo quando scoprii che Merrick era molto intelligente, che possedeva una sensibilità acuta e – ciò che è peggio – un'immaginazione romantica, che finalmente compresi la travolgente tragedia della sua vita.”
“Aveva una passione per la conversazione, ma per tutta la vita non aveva mai avuto nessuno con cui parlare.”
“Non aveva avuto un'infanzia. Non aveva avuto un'adolescenza. Non aveva mai provato piacere, Non sapeva nulla della gioia di vivere né del divertimento. La sua unica idea di felicità riguardava lo strisciare nell'oscurità per nascondersi.”
“ Era passato attraverso il fuoco e ne era uscito illeso. I suoi problemi lo avevano nobilitato.”
“Una cosa che mi aveva sempre colpito tristemente era il fatto che Merrick non potesse sorridere... Poteva piangere, ma non poteva sorridere.”
“Mi colpiva quando mi diceva che si era fatta strada nella sua mente l'idea, nell'ipotesi di vivere tra ciechi, di poter conquistare l'affetto di una donna, se solo fosse stata senza occhi per vedere.”
L'uomo Elefante e altri racconti di Frederick Treves è un piccolo capolavoro di verità, un'analisi estremamente attuale dell'uomo e della sua unicità.
Frederick Treves non descrive solo Joseph Merrick, l'uomo elefante, descrive me e forse tutti noi che ogni giorno lottiamo, nel centro del mirino, per farci accettare dagli altri semplicemente per quello che siamo.
Natalia Verginella
26 March 2021
20 February 2021
09 February 2021
SANGUE E LATTE di Eugenio Di Donato su LIBRI LETTI (Instagram)
Voto: 7+ Ho letto questo libro tutto d'un fiato, non solo perché è breve (poco più di 100 pagine), ma soprattutto perché è intenso. La trama, scarna ma essenziale, è solo il sottofondo dei veri protagonisti di questo libro: i pensieri. Ho trovato tante riflessioni interessanti, tra cui quelle sul rapporto genitori-figli; in particolar modo mi ha colpito la descrizione della vita dei nonni, così vivida e realistica.
Ciò che emerge di più dalla lettura di questo libro è l'urgenza dell'autore di comunicare, come uno sfogo (ma ragionato) ciò che ha compreso dalle sue esperienze. Oltre a quelle scritte, ho percepito anche tante parole non dette (non ancora, magari), che scalpitano per uscire fuori.
06 January 2021
18 December 2020
Sangue e latte di Eugenio di Donato su Artemisrory_bookclub - di Federica Piras
E così è stato: forte e genuino come il libro di cui ora voglio parlarvi.Ci troviamo in un castello di regole e rigida consuetudine; in aperta campagna, dove il tempo è scandito dai ritmi della semina, del raccolto e delle stagioni, sullo sfondo di una comunità riottosa al nuovo e di una famiglia vecchio stampo. Ma quel tempo è già trascorso, pur sopravvivendo nel presente.
Perché il nostro vissuto ci condiziona sempre, addossandoci il ruolo acclamato e richiesto dalla società. Perché non siamo null'altro che questo: un insieme sconnesso e vacillante di tradizione, abitudini e costumi ereditari. È incredibilmente difficile trovare la propria strada, avventurarsi al di fuori del caldo nido innervato dalla dea Educazione. È puro dolore recidere il legame con le origini, sofferta la lotta per sradicare la memoria, come far deragliare un treno lanciato in corsa lungo una traiettoria già segnata.
In poco più di un centinaio di pagine è condensata tutta l'essenza della fragilità umana, marchingegno difettoso e deciso a fermarsi.
Questa è la storia di Ludovico Travagli, che già nel nome porta i segni della sfida che si chiama vita.
"Latte e sangue", così si dice in Abruzzo per invitare chi si incontra a diventare uomo, a crescere ed evolvere. Ed è proprio questo il fulcro, l'Essenziale.
Non basta esistere per essere. Bisogna anche afferrare, stringere ciò che di buono la vita ha da offrirci.
Rinnegare il passato, questo no, mai: accettarne le implicazioni, perdonare se stessi sempre.
Aprirsi al dialogo, dismettere il giudizio: parlare e finalmente strapparci al vincolo alienante di castrazioni, a cui noi stessi, spesso, ci condanniamo.
Eugenio di Donato ha uno stile che ho amato moltissimo: direi "ermetico" e al contempo estremamente schietto, nudo, graffiante nella sua semplicità. Le parole sono come i tagli su tela di Fontana: ferite aperte, da cui trapela la luce. È stata una delle letture più belle di quest'anno, ha lasciato il segno.
Perché il nostro vissuto ci condiziona sempre, addossandoci il ruolo acclamato e richiesto dalla società. Perché non siamo null'altro che questo: un insieme sconnesso e vacillante di tradizione, abitudini e costumi ereditari. È incredibilmente difficile trovare la propria strada, avventurarsi al di fuori del caldo nido innervato dalla dea Educazione. È puro dolore recidere il legame con le origini, sofferta la lotta per sradicare la memoria, come far deragliare un treno lanciato in corsa lungo una traiettoria già segnata.
In poco più di un centinaio di pagine è condensata tutta l'essenza della fragilità umana, marchingegno difettoso e deciso a fermarsi.
Questa è la storia di Ludovico Travagli, che già nel nome porta i segni della sfida che si chiama vita.
"Latte e sangue", così si dice in Abruzzo per invitare chi si incontra a diventare uomo, a crescere ed evolvere. Ed è proprio questo il fulcro, l'Essenziale.
Non basta esistere per essere. Bisogna anche afferrare, stringere ciò che di buono la vita ha da offrirci.
Rinnegare il passato, questo no, mai: accettarne le implicazioni, perdonare se stessi sempre.
Aprirsi al dialogo, dismettere il giudizio: parlare e finalmente strapparci al vincolo alienante di castrazioni, a cui noi stessi, spesso, ci condanniamo.
Eugenio di Donato ha uno stile che ho amato moltissimo: direi "ermetico" e al contempo estremamente schietto, nudo, graffiante nella sua semplicità. Le parole sono come i tagli su tela di Fontana: ferite aperte, da cui trapela la luce. È stata una delle letture più belle di quest'anno, ha lasciato il segno.
11 December 2020
Recensione di Ombra mai fu di Luca Moccafighe - di Eugenio Di Donato
Ombra mai fu è una storia scritta in un italiano sorprendente, periodi lunghissimi si snodano lievi per pagine e pagine come se il flauto del fauno in copertina ne modulasse l’incanto. Racconta di due fratelli piuttosto brutti e quasi deformi che si dividono e contendono una sola ombra.
È la storia di un «difetto» impalpabile quasi a suggerire che in quanto tale non sia un vero difetto – «si parla del niente» – che simboleggia tutti i «diffetti», escrescenze impreviste e bizzarre che rompono la paciosa e rassicurante uniformità del conosciuto.
Ombra mai fu racconta del desiderio necessità di assomigliare a tutti i costi a ciò che esiste già, del bisogno impellente di «essere uguali», pena la morte, l’isolamento e la derisione continua da parte dell’altro. Della comunità che dovrebbe proteggere e che invece, simmetrica e omologata, dà prima del diverso, poi del matto e del demoniaco, e in fine addita come fuori posto. Una comunità inghiottita dalla stupidità, che incapace di riconoscere e riconoscersi trasforma l’inatteso in vittima e persino in carnefice di sé stesso, e nell’orgia dell’idiozia tutti insieme vittime e carnefici aizzano il mito della purezza e lo perseguono, e come ogni tentativo di estirpazione e rimozione di ciò che non è uguale a sé stesso, persino di ciò che non si può toccare, conduce al peggior scempio.
Eugenio Di Donato
08 December 2020
05 December 2020
Schopenhauerismo e amore per la natura in Diario del Gran Paradiso di Anacleto Verrecchia - di Marco Brignone
Diario del Gran Paradiso, ora ripubblicato da El Doctor Sax, è un libro prezioso, da leggere e da conservare con cura nella propria biblioteca.
Anacleto Verrecchia, a partire dall’età di ventiquattro anni, trascorse tre anni nel parco del Gran Paradiso, dal giugno 1950 al giugno 1953, e compose questi pensieri di natura prevalentemente aforistica.
Vorrei qui fare emergere, attraverso le parole dell’autore, il nesso tra il suo schopenhauerismo e l’amore per la natura.
Inizio con il considerare il tema dello stupore verso la natura. Egli scrive: «La filosofia non nasce forse, come dice Platone, da un sentimento di stupore di fronte ai fenomeni della natura? Ma il mondo è pieno di gente che parla di cose che non sente o che non conosce per esperienza diretta. I filosofi antichi erano così chiari, nelle loro esposizioni, proprio perché si basavano sull’osservazione diretta dei fenomeni» (p. 15). Per Verrecchia solo l’esperienza ha valore conoscitivo:
«Amo un solo tipo di caccia, quella delle idee. Girovagare su per questi monti, posare lo sguardo ora sullo stambecco, ora sulla roccia, ora sulla pineta ora sul filo d’erba, ora sul ruscello ora sui monti, ora sull’infinitamente grande come il cielo ora sull’estremamente piccolo come l’insetto: tutto questo allena la mente e non di rado riempie il carniere dello spirito. E se l’insetto è più eloquente del libro, io chiudo il libro e osservo l’insetto» (p. 248).
Per poter cogliere il pulsare dell’esperienza, però, occorre vivere in una condizione di solitudine: «I saggi non raccomandano forse di tenersi il più possibile in disparte dal gran mondo? E poi il silenzio è una condizione indispensabile per pensare e per riflettere. Chi non ama il silenzio non ama neppure la libertà» (p. 12). La montagna a questo riguardo è il luogo perfetto: «La pace e i grandi silenzi, i boschi a perdita d’occhio, i monti giganteschi e l’ampio cielo, verso il quale viene spontaneo di alzare gli occhi, danno ai nostri pensieri un indirizzo diverso. Si esce da se stessi e ci si immerge nei problemi generali, non individuali» (p. 81).
L’amore per la natura si traduce in Verrecchia non nel piatto binomio natura-civiltà, ma nella meditazione schopenhaueriana sul dolore insito nella vita e nella lotta per l’esistenza, che ovunque si manifesta:
«Tutto ho visto, la morte e la disperazione, il dolore e la lotta cruenta per la sopravvivenza. E chi dice che anche le piante non soffrano la loro parte? Spoglie e coperte di gelo, ora sembrano anch’esse piegate al dolore universale. No, meglio non guardare troppo a fondo nelle cose. Come il silenzio aiuta la tranquillità dello spirito, così una certa opacità tra noi e il mondo impedisce alla nostra coscienza di fare naufragio» (pp. 96-97).
Toccante è poi questa riflessione: «Lo sguardo degli erbivori è dolce come la loro indole. Ed è per questo che se la passano male. La dolcezza è un elemento estraneo alla vita e al mondo» (p. 297). Infatti «la vita, comunque la si viva, è un affare che non copre le spese. Per tutti» (p. 83).
Nel suo schopenhauerismo l’unione di tutti gli esseri ha una radice metafisica: «La nostra conoscenza riguarda il fenomeno, non la cosa in sé. Se uno riuscisse a conoscere se stesso come noumeno o cosa in sé conoscerebbe tutto il mondo, dato che tutti i fenomeni, nel mondo organico come in quello inorganico, traggono dalla stessa radice metafisica. La Volontà, come la chiama Schopenhauer, è unica: cambiano solo i modi e le forme di obiettivazione» (p. 276). Difatti «una è la forza che muove tutte le cose: la cascata che vien giù spumeggiando e la pianta che sale lentamente in alto, gli animali che si muovono sulla terra e gli astri che roteano in cielo. E una è anche la materia che le forma. L’unità nella pluralità» (p. 129). In tale concezione cosmologica organicistica «siamo tutti legati da un’intima parentela, perché tutti deriviamo dallo stesso principio metafisico. Ciò che si riflette negli occhi di un animale è la stessa volontà (intesa in senso metafisico) che si riflette nel mio e nel tuo sguardo. I naturalisti classificano gli animali, ma bisogna fare un passo più in là e riconoscere che gli animali, intimamente, non sono diversi da me e da te» (p. 283). Significativo è poi questo simbolo, quasi un axis mundi:
«Le piante possono in qualche modo simboleggiare la teoria del mondo come volontà e rappresentazione, come fenomeno e cosa in sé. Le radici, che non vediamo e quindi non conosciamo, possono simboleggiare la cosa in sé; la chioma, che invece vediamo e conosciamo, può simboleggiare il fenomeno. La morte della chioma non comporta anche quella delle radici, che gettano di nuovo. Ma anche il nostro vero essere, ossia la nostra radice metafisica, non viene distrutto dalla morte» (p. 274-275).
Il sentimento schopenhaueriano della compassione, inteso come partecipazione al dolore universale, oltre il principium individuationis, si concreta in queste pagine in una acuta attenzione verso gli animali: «Ciò che rende gli animali così gradevoli a vedersi è soprattutto la loro naturalezza. Essi vivono attaccati al filo del presente e hanno per così dire l’innocenza del divenire» (p. 13). Infatti «l’amore per gli animali, dice l’Avesta, è una via che conduce al cielo» (p. 38). La natura è essa stessa una forma di trascendenza: «Se proprio avete bisogno di un Dio, non cercatelo nel cuore dell’uomo, ma piuttosto nel canto degli uccelli, nel silenzio del bosco, negli occhi di un camoscio o nello scrosciare di un fiume» (p. 96).
Dagli uomini, per contrasto, è meglio tenersi lontani: «I fili spinati e le schegge di vetro sui muri di cinta delle proprietà private la dicono molto lunga sui rapporti umani. E poi si grida libertà, uguaglianza, fratellanza» (p. 238). E ancora: «L’animale non si rifiuta di allattare un figlio non suo, ma a Torino ci si rifiuta di affittare una camera a un siciliano o a un calabrese» (p. 268). Ne sono ben consapevoli gli animali: «La distanza che gli animali tengono rispetto all’uomo è inversamente proporzionale al nostro grado di civiltà» (p. 269).
In questo passo del 1951 Verrecchia annota in modo inquietante:
«La terra si va gradatamente inaridendo e riscaldando. Questo dipende dalla scomparsa dei boschi. Le Alpi, un tempo, erano perennemente coperte di neve e di ghiacciai. Ora, durante l’estate, le neve la si vede solo sulle cime delle montagne più alte, mentre il ghiacciaio della Grivola diminuisce di anno in anno. Lo si può anche notare dal colore meno scuro della roccia che il ghiacciaio lascia di mano in mano scoperta. E scompare, naturalmente, anche la flora. Un tempo questa arrivava a un’altezza molto superiore a quella del casotto, come dimostrano i vecchi ceppi di larice o di pino. Ora non più. Il nostro pianeta ha avuto un inizio e avrà anche una fine. Tutto ha un curriculum vitae» (p. 180).
Già allora, infatti, egli era consapevole dell’impatto negativo dell’uomo sulla natura:
«Tutto quello che scende in basso, laggiù dove vivono gli uomini, s’insozza. Penso a questi ruscelli così limpidi e puri, che vanno a portare la vita a sua maestà l’uomo. E che cosa ricevono in compenso? Tonnellate e tonnellate di escrementi, di liquami e di altre sozzure. Dal paradiso terrestre alla fogna: è questo il divino corso della storia di cui parla Hegel? Mi chiedo che cosa sarà del nostro pianeta fra cento o duecento anni, quando la popolazione si sarà almeno quadruplicata. L’uomo sarà pure l’animale più nobile, però è sporco e contamina» (p. 180).
Dure considerazioni riserva poi ai connazionali, definiti «anarchici per carattere e pappataci per vocazione»(p. 268), e «gitanti motorizzati» (p. 293):
«Gli italiani sono un popolo di sedentari, per non dire di pigraccioni e di mollaccioni. Non camminano e non amano la natura. A una bella camminata nel bosco preferiscono il ristorante, dove s’ingozzano di cibo fino all’inverosimile. Molti di quelli che incontro chiedono per prima cosa dove ci sia un buon ristorante, possibilmente “tipico”. Gli stranieri, invece, chiedono quasi sempre dove conduca questo o quel sentiero, oppure quante ore ci vogliano per attraversare questo o quel colle» (p. 270).
Egli individua una causa remota di questa incultura negli «gli stupidi dualismi come spirito e materia, uomo e animale, ecc.» (p. 24). D’altronde «chi è pigro nel camminare non ama la natura. Ma il parco bisogna visitarlo a piedi, non in macchina» (pp. 203-294).
Ci sono però uomini che non hanno perso innocenza e purezza, come l’amico Osello:
«La musica va sentita, non capita. Non si esprime per concetti. Molte persone, anche se colte, sono completamente insensibili alla musica. Infatti la cultura e l’erudizione non hanno niente a che fare con la sensibilità estetica. Il mio amico Osello non sa che cosa sia un diesis o un bemolle, ma se sente della bella musica si trasfigura. L’ho notato mentre ascoltavamo per radio brani di Wagner. La stessa cosa capita con la poesia. Quante volte gli ho letto brani dell’Odissea, dell’Eneide, della Divina Commedia o del Faust! E lui sempre teso ad ascoltare. Io preferisco di gran lunga la sua sensibilità, così genuina, alle chiacchiere di un erudito» (pp. 276-277).
Memorabile è poi questo splendido ricordo del filosofo Piero Martinetti:
«Fu uno dei pochissimi professori universitari (appena dieci su 1500) che rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà al fascismo. Gli amici lo abbandonarono subito, perché temevano di compromettersi. Accade sempre così in simili circostanze. Già Ovidio dice che come le formiche abbandonano i granai vuoti, così gli amici abbandonano chi cade in disgrazia. Ma Piero Martinetti, bastando a se stesso, non sentiva assolutamente la mancanza di amici, veri o falsi che fossero. L’innocenza degli animali, che egli amava moltissimo (non per niente era uno schopenhauriano e s’interessava di filosofia indiana), non gli faceva rimpiangere l’amicizia infida degli uomini. Lontano dai rumori del mondo, dove di regola regna la malvagità e comanda la pazzia, trascorreva il suo tempo nello studio e nella meditazione» (p. 265-266).
Occorre cercare la solitudine e il silenzio di questi alti spazi: «Nulla contribuisce alla tranquillità dell’anima come lo star seduti vicino a un ruscello e ascoltarne il rumore. È come se l’acqua che serpeggia tra i sassi si portasse via i nostri affanni» (p. 262). Così come la compagnia degli animali, lo stambecco, la marmotta, l’aquila, il merlo e il corvo: «Che cosa vuole comunicarmi il gracchio che mi guarda così attentamente? Ha un’aria assorta e sembra che rifletta anche lui sul proprio destino» (p. 274).
In questo dicembre, lontano dal Nivolet e dai luoghi incontaminati del parco, istituito novantotto anni or sono, mi è di consolazione leggere le parole di Anacoreta Verrecchia:
«Rimanere isolati dalla neve, senza la possibilità di ricevere o di trasmettere notizie al mondo, è un’esperienza incredibilmente piacevole e unica nel suo genere. Si è a contatto solo con gli elementi della natura e si prova un’ebrezza panica. Ci si sente, per così dire, reintegrati nella natura. È una specie di apocatastasi. I rumori del mondo e la commedia della vita sono lontani, e questo dà pace allo spirito» (p. 290).
Marco Brignone
5 dicembre 2020
30 November 2020
29 November 2020
25 November 2020
Recensione di Sangue e Latte - di Lavinia Stornaiuolo
“A furia di adattarmi mi ero snaturato”
Il punto esatto della presa di coscienza. Quello che arriva sempre nella vita, in un dato momento, forse il momento di maggiore improbabilità dell’esistenza. È lì che inizia il discorso.
Sangue e latte è una narrazione che si vuole sospesa, che si vuole doppia: profondamente radicata nel passato, nelle tradizioni, nel tempo ancestrale della superiorità dei ruoli e dei legami sociali, dei ritmi della terra e dei suoi profumi. È una narrazione che si vuole divisa, fra l’amore e il disagio, fra il sé sociale e il sé individuale.
Attraverso un movimento binario del racconto si tracciano molteplici dimensioni, mentre le stesse sortiscono i propri effetti in un gioco di cerchi concentrici in cui ogni riflessione, evento, ricordo, parola, inevitabilmente si inglobano vicendevolmente, costruendo le strade del protagonista, e tracciandone le vie interiori, sempre più intricate.
“Le cose dovevano essere perfette”
È qui che nasce la scissione interiore, nel cercare di definire la perfezione, di farne una misura del proprio mondo, quando invece la perfezione si rivela costantemente non esser tale, in tutte le sue forme. È la parola che svela, la parola che si offre come elemento sanatore. Ma è la stessa parola che svolge un duplice ruolo nella narrazione personale: affonda le radici nel tentativo inconscio di distruggerle, e nell’affondarle trova la forza per spingere oltre, verso una liberazione che ricombina gli aspetti dell’esistenza. La parola consente di non abbandonare il passato, ma al contempo esprime la profonda forza di fissare il passato, farne dipinto nella memoria, per poter riplasmare il presente, che è già futuro.
Sangue e latte è un manifesto della parola, nella misura in cui la stessa offre rinascita, oblio, ritorni. La parola come identità, capace di proiettare dentro per poi scaraventare fuori. Il discorso in cui ognuno può trovare le combinazioni attraverso le quali attribuire i sensi.
“Cominciare a interrogarsi su ciò che si vuole (...) Intensamente”
Subscribe to:
Posts (Atom)




















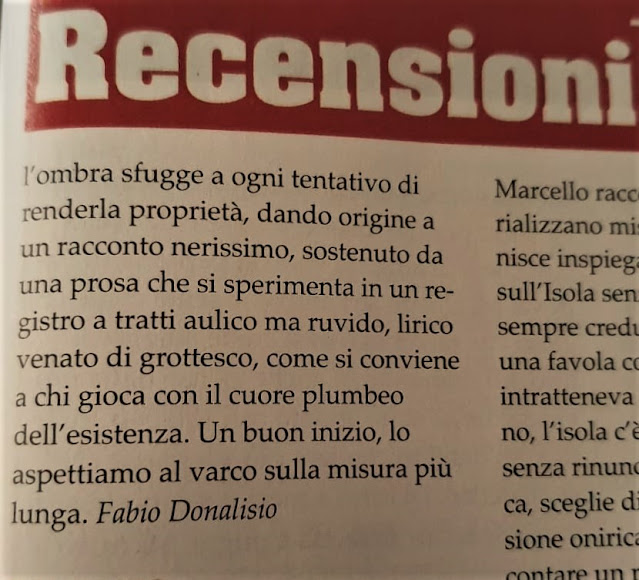
















%20____page-0001.jpg)





